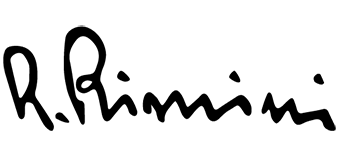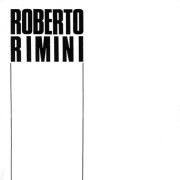Mostra retrospettiva del pittore catanese Roberto Rimini di Filippo M. Jelo (presidente E.P.T.)
Questa pubblicazione vuole significare un atto di doveroso e naturale omaggio per il Maestro Roberto Rimini nato a Palermo e vissuto a Catania. Sicilia occidentale e orientale fuse assieme nel cuore di un artista che spese tutta la sua vita in un perenne omaggio alla terra natale.
Un popolo è ricco per quello che i suoi figli migliori riescono ad assicurargli dei valori eterni che guidano il perenne divenire della umanità. Racchiudere alcune immagini del maestro Rimini in questo volume, dà a noi l’ambìto privilegio di proiettarci con Lui in una intima riscoperta di questa nostra amata Sicilia, bella calda, lussureggiante, che si offre a noi con i bagliori sanguigni dei suoi fiori e delle sue genti.
Leggi tutto
L’Ente provinciale per il Turismo, teso alla ricerca di motivi che possono attrarre e che possano costituire ricordo, non poteva non profittare dell’arte dell’illustre scomparso e nel ringraziare i famigliari del Maestro per la commossa partecipazione intende attestare gratitudine a quanti hanno collaborato: Prof. Raffaele De Grada, Prof. Ugo Ferroni, Prof. Vincenzi Indaco, Dott. Vittorio Murer della Sinet, Dott. Salvatore Nicolosi, Prof. Nunzio Sciavarrello e il Direttore di questo Ente, Dott. Alberto Colajanni.


Sicilia e poesia in Roberto Rimini di Raffaele De Grada
Un gruppo di pescatori avvolti nelle loro reti come se fossero con esse una cosa sola si avvia verso il mare che davanti si allontana in un orizzonte a perdifiato, qualche barca ferma il primo piano sì da non confonderlo con l’enorme fondale, il colore di una casa a sinistra fa da quinta allo scenario. Poche opere come questa di Roberto Rimini mi danno l’idea della Sicilia della costa orientale, nella semplicità e maestria del disegno. Siamo ben lungi dai soliti pescherecci attraccati al molo di tutto il pittoresco dell’Ottocento che ha continuato per decenni a rappresentare questa emozione di natura. È questa stabilità dell’immagine della sincerità dell’emozione del reale, è questa severità della condotta pittorica che mi hanno pienamente convinto della necessità di un tasto e una mostra di omaggio allo scomparso Roberto Rimini, nella iniziativa presa con giusta scelta e amorevole condotta dall’Ente del Turismo di Catania.
Leggi tutto
Rimini era palermitano di nascita ma a Catania era vissuto fin da bambino e soprattutto con la sua opera aveva dimostrato il suo grande amore a questa terra.
Sempre più amò gli artisti che si legano strettamente alla propria terra, nei quali si riconosce un luogo, un tempo e una storia. E Rimini è certamente il migliore di questi artisti che portano avanti il realismo pittorico che viene dall’Ottocento in Sicilia, dove esso non aveva tradizioni così forti come in Piemonte e in Lombardia.
Purtroppo pittori come Rimini, pur confortati da un ambiente di cultura (si ricorda la stima che di lui ebbe Federico De Roberto, la sua amicizia con Giuseppe De Logu col quale visse accanto a Venezia per un certo periodo), dipingendo sulla scia del realismo pittorico dell’Ottocento, sono stati sottovalutati in un secolo che ha voltato le spalle al naturalismo. Riprende semmai ora, pur nelle forme di un verismo fotografico, l’attenzione per la pittura del tipo di quella di Rimini. La tendenza astratta ha oscurato tutte quelle forme d’arte che invece di esplorare nuove tecniche mirano ad esprimere consolidando quelle abituali la poeticità di un mondo reale.
Per la verità Salvatore Nicolosi, qui accanto, ci dà notizia di un primo approccio di Rimini con forme e tecniche strane di espressione. Ma di esse non esiste più alcuna traccia né come documento né come passaggio nell’opera di Rimini che noi conosciamo e che conta. Si sa invece che Rimini cominciò a studiare nel 1905 all’Istituto di Belle Arti di Napoli con lo scultore salernitano Stanislao Lista, un verista convinto. Sono gli anni in cui si prepara anche in Italia il fenomeno «dell’avanguardia storica» (si pensi al primo Boccioni). Il Lista, valido scultore, non era certo di quelli che si mettono a correre dietro alla trovata. Stava ben fermo sulle posizioni acquisite dalla scultura verista napoletana, al seguito di Gemito e di Achille D’Orsi. Le inquietudini del giovane Rimini andavano oltre la scuola del Lista. Cambiò addirittura città, andò a Venezia con De Logu e si iscrisse a quella Accademia di Belle Arti dove allora trionfava il celebre Ettore Tito.
Si può ritrovare la radice di Tito nell’opera di Roberto Rimini?
Ho davanti a me una composizione di paesaggio e un vaso di fiori appoggiato su un tavolo tondo visto di scorcio di Rimini.
È un’opera del 1921 (coll. D’Amico).
È tanto diversa dal tipo di «natura morta» che negli anni Venti comincia a prevalere, fino ai peperoncini e pomodoretti di Mario Mafai. Nelle «natura morta» novecentista e postnovecentista il pittore mira a razionalizzare le strutture primarie del colore e, specialmente in quella novecentista, dell’ombra e luce, del chiaroscuro.
Nel quadro di Rimini prevale tutt’un altro concetto: il gusto grafico del vaso liberty, la rappresentazione aperta, nella luce autentica del sole siciliano, della sua flora ricca e felice, la libertà da ogni vincolo teorico che intanto cominciava a giocare nell’arte italiana, ci fa mettere in diretto rapporto questa opera non tanto con la natura oggetto di ricerca, che fu proprio del Novecento, quanto con quella pittura in cui si espandeva l’unità tra l’uomo e il suo prodotto, senza mediazioni intellettuali che fu proprio del Novecento, quanto con quella pittura in cui si espandeva l’unità tra l’uomo e il suo prodotto, senza mediazioni intellettuali, che fu propria della pittura italiana, specialmente a Venezia, e che non ha ceduto al Novecento se è continuata fino a oggi, come ci ha dimostrato appunto una recente mostra, proprio a Venezia, del veneto Barbisan. È una pittura dove il museo esce all’aria aperta e si scioglie nella luce conservando alla pittura di tradizione appena quel tanto di impalpabile, di estatico che è proprio delle atmosfere rarefatte del museo ma dove la vita vince col suo clamore felice nelle fronde degli alberi delicatamente intrisi di aria, nella tenerezza pastosa del petalo che si tocca nel suo piacere di velluto.
Tutto ciò è il taglio scenografico che Rimini conserva alla sua pittura di contenuto «sociale» che culmina con il grandioso Lavoro nei campi (1933, della Camera di Commercio di Catania) che è stato certamente da lui assorbito dalla scuola di Tito a Venezia. Quando Roberto Rimini tornò a Catania, nel 1914, dopo due anni di perfezionamento a Roma, la sua preparazione aveva veramente un respiro nazionale. Il pericolo del provincialismo era scongiurato.
Catania, la Sicilia dell’altro dopoguerra, perché con quella, avendo passato ben quattro anni in guerra (1915-1919) Roberto Rimini dovette fare i conti. Che cos’era allora, dal punto di vista dell’arte figurativa, la Sicilia?
Intanto si dovrebbe parlare dell’importanza che ivi aveva la pittura dei pupi, quella dei grandi cartelli pubblicitari, chiamati «abbattuti», nella quale si erano distinti alcuni catanesi come Francesco Vasta e Sebastiano Zappalà, lodati da Pirandello e da Mascagli.
La «pittura dei pupi» e dei carretti ha avuto un grande peso e grandi meriti in Sicilia, prima di tutto quello di aver dato all’arte siciliana un contatto vivo col popolo, attraverso una specifica funzione sociale e fantastica del pittore che si abituava a immedesimarsi col popolo. In nessun altro ambiente italiano c’è stato un rapporto così diretto tra artisti e popolo, con una sorta di coscienza «artigianale», come nel tempo antico, dei pittori che in tutto il resto d’Italia si affermavano intanto attraverso cenacoli, gruppetti e, corrompendosi poi la situazione, in vere e proprie ganghe, talvolta. Come figurazione la pittura dei pupi e dei carretti ha influito su alcune personalità siciliane anche molto notevoli come Pippo Rizzo. E perché non vederne una eco perfino in Guttuso e Migneco?
Gli incontri con i vari ambienti – Napoli, Venezia, Roma –, la scuola di Ettore Tito, il carattere «nazionale» con cui si presenta Rimini dopo il 1919 sembra che distolgano ogni rapporto tra la sua arte e quella dei pittori di pupi e di carretti. Fin da principio – e continuerà su quella strada con incredibile coerenza fino alla fine, ne sia esempio la bellissima sanguigna dei Pescatori, coll. Anello, che è dal 1969 – Rimini ha fatto una scelta, una scelta più letteraria che strettamente pittorica: ha scelto per Giovanni Verga, per l’amore doloroso verso i suoi pescatori, contadini, pastori. Per Rimini, uomo colto, scegliere per Verga piuttosto che per Proust, cioè secondo una cultura che intanto andava affermandosi in particolare nella Firenze di quegli anni, dove nasceva una vista come Solaria, aveva un ben preciso significato.
La scelta verghiana che si concretava anche nel comportamento del pittore (Rimini si appunta intorno a precisi luoghi di lavoro: Milo, Catona in Calabria, la Piana di Catania, Acitrezza) lo distingue dal comportamento di un lavoro di pura fantasia com’è quello dei pittori «pupari» o di «carretto», anche se in loro il realismo popolare agisce in modo diretto. L’arte di Rimini è esplicita su una realtà sociale. Nessuna influenza diretta quindi su Rimini da parte dei pittori di cui dicevo, pupi e carretti, ma come in loro esiste in Rimini la tendenza ad aprirsi a un discorso di massa, ai limiti del populismo, invece che ad un colloquio di élite, tendenza principe dell’arte italiana degli anni Venti.
Bisogna quindi chiarire in quale direzione si muoveva la ricerca «realista» di Roberto Rimini, considerando le grandi linee della tendenza realista fra le due guerre.
Una linea è quella che si impernia nel costruttivismo russo, in piena azione dopo il 1920 per l’impulso datogli principalmente da Majakovskij e dal teatro di Mejerchoed e Stanislavskij.
Niente, a incominciare dalla didattica dalla quale Rimini proveniva, ci fa pensare che Rimini abbia considerato quelle forme d’arte che probabilmente neppure conosceva.
Il realismo tedesco e tutto l’espressionismo che gli è consanguineo. Gli espressionisti vedono la patologia del dramma umano, nella stessa cronaca mettono in evidenza le situazioni di disperazione, rapportate all’uomo considerato come individuo. La loro aspirazione a un ridimensionamento della vita nel collettivo si fermano ad un anelito di libertà individuale.
L’intervento critico di Rimini sul reale parte da una tendenza del tutto opposta: il peso e la dimensione plastica di Rimini si concretizza in una realtà di equilibrio sostanzialmente felice. Guardo quella splendida composizione a sanguigna che si intitola L’ora del riposto: quei contadini seduti alla mensa rudimentale in mezzo ai campi si astraggono felici nel panneggiamento dei loro poveri abiti da statua gotica realistica. È come se vedessimo la fata morgana nel deserto. Chi si ricorda più della fatica?
Rimini ha costruito un’oasi avviluppata di sole nell’incanto di un paesaggio dove le lontananze dei monti sono come le volute di una splendida architettura divina. Nulla traspare di un eventuale dramma «espressionista» delle coscienze.
Diverso è il discorso per quanto concerne eventuali rapporti tra l’arte di Rimini e il realismo tedesco, quello di Grosz, Dix, Grundig ecc. Per approssimarci al discorso dobbiamo subito riflettere alla differenza profonda ch esiste tra il realismo verghiano, siciliano, tutto impostato sulla natura, sulla conservazione dei beni umani del popolo siciliano, mentre la protesta è ancora tutta chiusa nei meandri dell’inconscio, e quello dei realisti tedeschi dove essa erompe come pensiero di libertà, come volontà mentale che assume attraverso l’arte lo spessore della fantasia e del sentimento. Piani totalmente diversi.
Giova piuttosto ricollegarci, per quanto riguarda un certo aspetto dell’arte di Rimini (e penso a certe sanguigne spiritualmente intime come Meriggio, 1969, coll. Rimini, o a disegni come Il bagno, 1936, della stessa collezione) a quella espressività antisimbolista, tutta presa dal racconto cui si piega una tecnica attenta e peritissima che fu propria degli antecedenti del realismo tedesco del nostro secolo, parlo di Menzel, di Corinth, di Slevogt.
Specialmente nel disegno, nell’ombreggiatura, nel modo come è usata la pasta del carboncino, nel variare dello spessore del segno.
Conosceva Rimini questi artisti? Basta pensare ai suoi soggiorni veneziani e romani, all’utilità culturale delle Biennali veneziane di quel periodo e alle mostre degli Amatori e Cultori di Roma, per rispondere con convinzione che certamente Roberto Rimini conosceva quegli artisti. Del resto prima della guerra del 1914 la cultura della Mitteleuropa e della Germania era da noi quasi più larga della conoscenza dell’arte francese.
Un terzo filone del realismo, allora ben poco noto, esiste nel nostro secolo: è quello dei messicani, i tre grandi – Rivera, Orozco, Siqueiros – e di vari altri artisti molto rilevanti. Vere e proprie parentele tra Rimini e questi pittori e incisori, non ne troviamo.
Ma anche in questo caso giova rifarsi a un atteggiamento comune verso il reale: all’uno e agli altri interessa la figura e il racconto per i contenuti, comune è la considerazione dell’uomo nella sua fatica, nella sua realtà di associazione e di contatto, posizioni tanto diverse non solo da quelle della pittura ufficiale del periodo ma anche da quella per così dire di opposizione (da Sironi a Scipione, per intendersi, riferendosi sempre ad artisti che entrano nel vivo del reale). Come esempi posso portare di Rimini la tempera La fatica, del 1963, e il disegno Conversazione, 1967.
Da quanto precede si comprende come Roberto Rimini rimase tagliato fuori dai grandi interessi critici e mercantili italiani ed europei. Mentre le alchimie pittoriche svariavano da Le figlie di Loth (1919) di Carrà alla pittura «aldilà dello specchio» dei surrealisti, in quegli stessi anni Roberto Rimini dipingeva il paesaggio di Taormina, dove soggiornò dal 1927 al 1934, oppure si affaticava intorno ai temi della vita agreste in grandi quadri come La trebbia (1928) o Al pozzo (1930).
Oggi tutti gli artisti si commuovono per le limitazioni di libertà subite dagli artisti del nostro secolo ogni volta che qualcuno ha criticato la difficoltà di comprensione, di comunicabilità che sono insite nell’arte moderna quando ti presenta alcuni segni difficilmente intelleggibili come «figura» oppure la deformazione come unica condizione di modernità. Molto arduo rendersi conto oggi che quando Rimini dipingeva un quadro come Lavandaia (1926) o come Pane (1922) quella era per Rimini un’affermazione di libertà, una forma di creatività per quanto cesellata essa fosse nei particolari dell’erba di un prato, nei vimini di un cesto.
Fu quasi un eroismo per un uomo di cultura come Rimini essere andato per la sua strada senza aver ascoltato il richiamo di una facile mondanità culturale in tutti gli anni in cui, insieme a Francesco Pastura (per il cui libro Mandrie rosse Rimini fece un gruppo di litografie) andava componendo nelle campagne di Vizzini e di Libertinia immagini così perfette di muli e di cavalli, di portatrici di acqua e di contadini fermi nella sosta dal lavoro.
Rimini, come del resto tutti gli artisti del suo tipo chiuso e operoso, esponeva poco. È cosa del mercato attuale l’abitudine alle continue esposizioni in ogni parte, mentre i «maestri» sfornano quadri nel cliché preferito dal pubblico. Rimini aveva esposto a Catania, ormai la sua città, nel 1924. Vi espose ancora nel 1935 (nel marzo, alla galleria Arbiter di via Etnea) nel momento della sua piena maturità. Dalle immagini squillanti della sua gioventù (i vasi di fiori fasciati di sole e d’aria o quadri come La nassa, 1922, coll. Del Bufalo) Rimini era giunto a forza di lavoro e di approfondimento alla visione distesa, non più frammentaria e postimpressionista, della natura siciliana considerata nella sua totalità, in senso anche panoramico. Il «panorama», la «veduta» sembrano più facili e corsivi rispetto al particolare cui ci ha abituato la pittura moderna, invece richiedono una capacità di costruzione di cui il naturalismo non è sempre all’altezza. Quadri come Marina calabra (1923-33, coll. Garipoli), potrebbero oggi diventare il centro di una mostra «ecologica» tanto la festa della natura è dolcemente goduta in tutti i suoi piani differenti: la spiaggia nutrita di sole, il mare che si differenzia come materia e che ci fa sentire la stessa gioia di quando facciamo un bagno in piena estate, i monti della Sicilia in fondo che hanno perso ogni gravità, il cielo, un vero cielo. È difficile trovare un altro paesaggio che ci dia la stessa sensazione globale della felice terra dello Stretto. Se merito del paesista è quello di tipizzare la natura, questo quadro di Rimini corrisponde per la natura dello Stretto a quel che sono alcuni pascoli di montagna di Segantini o, quelli più umidi, di Fontanesi. Per arrivare a tale pienezza di espressione non bastavano certo le doti naturali, ci voleva una cultura, una autentica cultura.
Dopo tanti decenni in cui siamo stati abituati a trattare la storia dell’arte contemporanea secondo «tendenze», sembra che il privilegio della cultura sia soltanto delle «avanguardie», del surrealismo e dell’arte intellettuale. Non si riesce a capire quanta cultura ci vuole per superare la banalità nell’ambito del naturalismo. Rimini che viveva in mezzo a uomini di cultura e a letterati e che aveva ricevuto, come abbiamo detto, dalla prosa verghiana il suo primo indirizzo, aveva studiato con molta intelligenza il suo paesaggio, la luce particolare della Sicilia col vero, il quadro sembra sempre più buio della luce reale. Non così quello di Rimini che, a forza di studio, era riuscito a rendere la «vera» luce siciliana. Vitaliano Brancati l’aveva capito quando scrisse: «Sembra che Rimini abbia avuto l’incarico di illuminare i quadri degli altri».
Brancati aveva compreso la differenza della luce tra i quadri di Rimini e quelli degli altri.
Come questo miracolo? Rimini lo doveva prima di tutto al proprio comportamento di pittore realista. Si sentiva a suo agio in mezzo alla sua gente, i pescatori, per esempio. Non era più difficile per lui interpretarli nella loro realtà. C’è chi dipinge, fermandosi all’aspetto del vero, e chi interpreta. Se si guarda una tempera come Uomini in barca (coll. Condorelli) si vede come l’interpretazione del gesto del pescatore sia andata molto oltre la contemplazione del «genere». Senza fare il ritratto puntuale di quei volti, Rimini ce li fa riconoscere meglio che se li mettesse in posa.
Ma anche quando il paesaggio si spopola di figure e si avverte che il pittore cerca l’angolo della pura fantasia, quella che il nostro secolo ha tentato con le foreste di Rousseau il Doganiere e che tanti altri sono andati a cercare negli angoli remoti della loro esistenza, anche se si sono fermati agli aspetti del vero, Rimini riesce a darci sensazioni nuove, sognate, eppure veramente realistiche del paesaggio siciliano. Si guardi un quadro come La nuvola bianca (1940, coll. D’Amico) con l’albero che gravita nello spazio panoramico e si accampa gemello dell’uomo a raccontarci una vicenda remota. È la stessa sensazione della Sicilia dove sbarcarono i greci che ha il principone del Gattopardo quando va a caccia il giorno del plebiscito e misura su quello spazio eterno dei colli siciliani la pochezza della cronaca che qualcuno poi potrà anche chiamare storia.
Si giunge così al nodo dell’arte di Roberto Rimini che si accentra nell’impegno di tutta una vita dedicata alla conoscenza più profonda del paesaggio e della gente siciliana, una sorta di linea divergente rispetto all’arte di ideologia che ha avuto fortuna nel nostro secolo. Dalla marina di Acitrezza alla montagna di Zafferana (dove Rimini passò gli anni di guerra) la solitaria ricerca di Roberto Rimini si collega a quella degli altri artisti italiani che hanno preferito la realtà della natura e della società all’incontro di équipe nella tendenza intellettuale. Mi sembra di aver definito che non fu la sua una fuga dalla «cultura», tutt’altro, fu l’assunzione di un compito culturale ben preciso che è quello di portare avanti la conoscenza estetica di un mondo che ha una sua storicità precisa e una sua poesia che si affida, dalle radici del passato, al futuro.
Chi guarda oggi le opere di Rimini potrà rilevare che tutte le ricerche intellettuali delle correnti astrattiste e consimili sono rimaste assenti dalla sua arte. Anche le ricerche novecentiste lo hanno toccato appena di striscio. Non per questo l’arte di Rimini resta nell’angolo secondario della provincia italiana. Si consegna invece come l’opera di un realista concentrato nella definizione della Sicilia che abbiamo conosciuto fino a oggi, la Sicilia popolare dei pescatori e dei contadini, quella cui voleva bene Concetto Marchesi e tutti gli altri che hanno tenuto alto il nome pulito e autentico della Sicilia che ha i suoi pittori da schierare con onore nel territorio ricco dell’arte italiana.
Roberto Rimini nel suo tempo di Ugo Ferroni
Inserire Roberto Rimini entro l’ambito della cultura figurativa catanese nel decennio tra il ’20 e il ’30 – gli anni, cioè, della sua più cospicua attività – non è impresa molto agevole per la mancanza di precisi termini di riferimento.
Erano quelli, è vero, gli anni ruggenti della cultura catanese, quando sui marciapiedi di via Etnea, il vero salotto, allora, della città, si potevano incontrare – scomparso da pochi anni Luigi Capuana, e ancora per poco tempo presente Giovanni Verga – la signorile figura di Federico De Roberto, e poi, citando alla rinfusa, Natale Scalia, Giuseppe Villaroel, Ferdinando Caioli, Salvatore Lo Presti, Ercole Patti, Antonio Prestinenza, Ottavio Profeta, Giuseppe Patanè, Saverio Fiducia, Vito Mar Nicolosi, i due Manzella, Aniante, Enzo Maganuco, tutti più o meno giovani, fino al giovanissimo Vitaliano Brancati già visibilmente destinato alla gloria.
Leggi tutto
Già negli anni precedenti una gloriosa rivista redatta da Antonio Bruno e Giovanni Centorbi, e che persino il De Robertis aveva citato come una delle più serie riviste italiane (Pickwick), aveva tenuto viva la tradizione culturale catanese, ed era stata poi seguita da altre riviste tra le quali ci piace ricordare l’«Albatro» del compianto Mimi Lazzaro, pittore scultore e poeta allora giovanissimo.
Ma il centro ideale intorno al quale si coagulavano questi fervidi ingegni fu il Giornale dell’Isola letterario, il settimanale fondato da Carlo Carnazza, che per 5 anni, pur senza una ben precisa fisionomia né indirizzo estetico, additò ai catanesi le nuove vie della cultura nazionale ed europea.
Tra questi uomini Rimini visse il suo primo soggiorno catanese, ad essi si legò di amicizia, con essi, soprattutto partecipò al rinnovamento dell’arte isolana.
Nel campo figurativo, purtroppo – lo abbiamo già accennato – Catania non poteva annoverare nomi illustri come nel campo letterario.
Una tradizione che aveva visto rifulgere i nomi dello Sciuti, dell’Attanasio, del Reina, dei Gandolfo, di Michele Rapisardi, (e potremmo citarne altri ancora) andava via via spegnendosi e, del resto, nessuna indicazione, pur nella sua indiscutibile validità, poteva dare al giovane pittore che aveva dipinto, per citare le prime opere che ci vengano alla mente, quei magnifici paesaggi calabresi e alcune delle più belle figure femminili.
Null’altro che un’indicazione di serietà e di impegno di mestiere potevano dargli le pur prestigiose opere di quei maestri, diversi essendo i problemi del giovane artista, tutto volto ad un mondo nuovo al quale aveva aderito nei suoi soggiorni romani e veneziani, al di fuori del mondo accademico, e che ora trovava conferma nelle discussioni e nell’opera di quei letterati.
Non era un rivoluzionario, non aderiva ai nuovi indirizzi che col futurismo e poi con gli altri movimenti culturali di quel primo trentennio del secolo portavano una fosca ventata d’aria all’esausta tradizione figurativa italiana e che qui a Catania cominciavano a far capolino più tardi con la presenza di Lazzaro, di Romano, di Perotta, di Barbero, tutti giovani che egli del resto apprezzava e coi quali strinse legami di amicizia, senza per altro lasciarsi influenzare. Ma non era neanche un accademico, che anzi conduceva una silenziosa polemica (il silenzio, la discrezione, è sempre stata la caratteristica di Rimini uomo e arista) contro la bolsa prosecuzione di una tradizione ormai scaduta, che lui invece inverava con una libertà, con un piglio talmente nuovo, che ne faceva l’unico punto di riferimento sicuro in quello squallido panorama.
E chi scrive ricorda lo stupore suscitato dalla sua prima mostra catanese del 1927 nel salone del palazzo comunale, presentata da Federico De Roberto.
Non era – ripetiamo – la mostra di un rivoluzionario, ma stupì i suoi concittadini per la novità dell’impostazione, per certe libertà iconografiche, ma soprattutto per lo stupendo impasto coloristico memore della migliore tradizione veneziana che era confluita in lui durante il suo soggiorno lagunare trovandovi una disposizione d’animo affatto congeniale, anche se atteggiata in maniere del tutto diversa poiché mai l’impasto cromatico indeboliva la plasticità delle sue figure e dei suoi sfondi.
Con questa mostra Roberto Rimini dava già la misura della sua statura d’artista e nel medesimo tempo la sua capacità di rimanere se stesso pur partecipando attivamente ai vari movimenti culturali.
Le sue amicizie che, come si è detto, erano in maggior numero in campo letterario che in quello figurativo, se molto contribuirono alla formazione della sua personalità, per nulla influenzarono la sua produzione: nulla di letterario si riscontra infatti nella sua pittura, nulla di voluto, di ricercato, d’intellettualismo, ma una forma tutta nuova, semplicissima nei suoi dati esteriori, e pregna al tempo stesso di una tradizione assimilata e dominata con una padronanza di linguaggio già pienamente raggiunto, già maturo, che andrà via via approfondendo negli anni successivi, arricchendolo di nuovi problemi ma pur sempre chiaro e leggibile.
E di fronte all’incalzare delle nuove mode, di fronte anche – non bisogna dimenticarlo, perché è uno dei segni della sua grandezza – all’affermarsi di giovani che a Catania portavano, come abbiamo visto, le ventate innovatrici dei centri d’arte – e nel corso degli anni molti altri se ne aggiunsero – egli seppe sempre mantenere la propria indipendenza, il proprio prestigio di maestro riconosciuto e ammirato anche da quei giovani pur tanto diversi da lui, e rappresentare nel modo più nobile fino ai suoi ultimi giorni una tradizione che in altri era quasi sempre scaduta e puro illustrazionismo.
È questo il grandissimo merito di Rimini pittore, è per questo che lo ricorderemo sempre come uno dei nostri migliori artisti, oltre che come uomo di eccezionali qualità.
Ma dell’uomo Rimini altri si è assunto il compito di parlare.


Vita semplice di un artista di Salvatore Nicolosi
Due date, 1888-1971, e due parole, arte e famiglia (le direste un motto araldico). C’è in esse quasi tutta la biografia di Roberto Rimini. C’è perlomeno, ciò che della sua biografia conta realmente. Quelli che restano non sono che episodi, e nessuno di essi determinò una svolta, nessuno riuscì a scalfire la sua coerenza di uomo e di artista.
Secondo di nove figli, Rimini nacque il 24 marzo 1888 a Palermo; ma, come Federico De Roberto scrisse nell’aprile 1927, «a Catania fu portato da bambino, di Catania apprezzò la parlata, a Catania cominciò i suoi studi, e qui tornò dopo averli compiuti». (In quell’anno si teneva al palazzo comunale una delle prime mostre il 26 luglio, De Roberto sarebbe morto).
Leggi tutto
La sua famiglia soleva trascorrere le vacanze estive alla periferia di Catania, a Barriera del Bosco, che era allora un quartiere a mezza strada fra la città e la campagna, più vicino a questa che a quella. E in campagna il giovane Roberto faceva frequenti incursioni, assieme all’amico Giuseppe De Logu (che sarebbe divenuto più tardi direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove il pittore avrebbe trascorso una lunga fase, la seconda del suo noviziato). Durante queste gite, delle quali si trova testimonianza nel suo diario, si devertiva a «sparare su nu galletto anemometro, e nelle pause dipingeva sciancati inverosimili, con mostruose stampelle»: reminescenze di Bosch o Grünevald?, o anticipazione dei surrealisti?
Furono i suoi primi approcci con la tavolozza, improntati a un cerebralismo che molto presto egli avrebbe rinnegato; valsero comunque a fargli scoprire la sua vera vocazione, in contrasto con gli studi tecnici che aveva intrapresi e che seguiva con scrupolo ma senza amore. Il padre vagheggiava per lui – ogni padre corre dietro a un sogno, che sovente non coincide con i programmi del figlio – una carriera di ingegnere, ma dovette arrendersi dinanzi alla fermissima volontà del regazzo. A diciassette anni, nel 1905, Roberto si iscrisse all’Istituto di Belle Arti di Napoli, dove seguì le lezioni di Stanislao Lista, scultore salernitano. Questa iniziazione, sotto la guida del «poderoso scultore che aveva plasmato il Leone ferito nel monumento ai Martiri partenopei» avrebbe lasciato in lui una traccia incancellabile: educato alla sua scuola, Rimini avrebbe sempre costruito figure plasticamente plausibili, immagini autentiche, mai irreali o gratuite. Immagini vere, cioè, che, si legavano a quel verismo leterario e artistico del quale egli era seguace.
Il glorioso istituto napoletano cominciò, quasi repentinamente, a perdere prestigio ed autorità quando, nel 1901, morì il suo direttore, Domenico Morelli. Due anni dopo, quando la decadenza era conclamata, l’ansioso ricercatore della «verità» pittorica si trasferì a Venezia, per respirare altre atmosfere. Fu all’Accademia di Belle Arti per sei anni, allievo di Ettore Tito, che fu il suo vero e più grande maestro, colui che gli insegnò «il segreto della pittura in piena aria». Infine si diplomò e, terza tappa, passò a Roma, a compiervi per un anno studi di perfezionamento.
Contiamo questi ani di paziente coscienzioso tirocinio: due, più sei, più uno, fa nove. Nove anni di studio, non pochi; ma era una severità in quei tempi (oggi non più) indispensabile e usuale.
Nel 1914 tornò a Catania. Nel suo «bagaglio» custodiva un piccolo «tesoro»: la lode calorosa e incondizionata che Adolfo Venturi, il grande critico e storico dell’arte, gli aveva appena appena tributata. Era un ecellente viatico, che gli diede entusiasmo e ottimismo.
Cominciò a lavorare di lena. Ma per poco: in quello stesso anno dovette partire per prestare servizio militare. Quattro anni, prima come soldato poi come ufficiale, anni di guerra, trascorse al fronte, Nel 1919, finalmente, tornò a casa capitano. Riprese a lavorare, ancora con entusiasmo, riprendendo scene della vita di campagna, specialmente a Milo, paesino sull’Etna, dove saliva insieme con l’amico Natale Scalia, scrittore e critico.
Il risltato d un quinquennio di lavoro fu consegnato al giudizio del pubblico nella sua prima mostra personale, 1924.
Cominciava il lungo cammino, che sarebbe durato mezzo secolo, In quell’anno stesso conobbe a Catona, in Calabria, durante un soggiorno di lavoro, la donna che avrebbe sposata l’anno successivo e che gli avrebbe dato cinque figli. E frattanto lavorava, e ammirava Verga. Quasi inconsapevolmente ne aveva assorbito la lezione e ne rispecchiava il mondo: i pastori di Milo, i contadini della Piana di Catania, più tardi i pescatori di Acitrezza.
Benché nato sette anni dopo la pubblicazione (1881) dei Malavoglia e nell’anno stesso (1888) del Mastro don Gesualdo, Rimini – anche lui verista – non può esser considerato tuttavia un allievo, né un imitatore, di Verga. Non reminescenze né imitazioni sono le sue; piuttosto consonanze. Quei luoghi e quei personaggi, quei silenzie e quelle solitudini, aratri e barche, zappe e reti, marine e montagne: sono il mondo verghiano e sono il mondo che Rimini – autonomamente anche se con devozione artistica verso il grande Maestro – ripercorreva ora, finché Verga visse e anche dopo che Verga morì. Vero, o verista, il modo dello scrittore; vero, cioè alieno dagli artifizi, il mondo del pittore.
Le tappe ulteriori della sua vita non furono molte: appena quattro.
C’è un lungo interludio di Taormina, dove egli si era recato con la famiglia per un’estate e dove, incantato dallo scenario paradisiaco, si fermò invece per sette anni, dal 1927 al 1934. Lì la sua produzione fu intensa e fervida, in parte tuttoggi conservata negli alberghi più lussuosi (il San Domenico, il Timeo, Villa San Pietro), in parte subito acquistata e portata via da un pubblico cosmopolita. In quegli anni il direttore di una galleria di New York, turista a Taormina, lo invitò a trasferirsi per qualche tempo in America. Ma l’indifferenza che egli aveva per i vantaggi materiali e d’altro canto l’amore per la famiglia lo indussero a rifiutare.
C’è il ritorno a Catania, una lunga stagione iniziata nel ’34. Nei primi di quel periodo peregrinò per le campagne suggestive di Vizzini e Libertinia, al confine sud-ovest della provincia, insieme con il maestro Francesco Pastura – attento biografo ed esegeta di Vincenzo Bellini, ma stavolta in veste di demopsicologo, – il quale stava raccogliendo canti popolari per un suo libro, che sarebbe stato stampato anni dopo, nel 1939, illustrato da alcune litografie di Rimini: Mandre rosse: paesaggi, uomini e canti di Libertinia, titolo, se vogliamo, piuttosto riduttivo per un’opera che aveva un respiro più ampio. I buoi aggiogati, i contadini col capo avvolto nel fazzoletto annodato sulla nuca, il turbinio delle trebbiatrici, i covoni solenni e incombenti, il sole cocente – insomma il lavoro dell’uomo e la fatica che è il prezzo della sua vita – erano i temi universali del vivace commento grafico che Rimini aveva realizzato.
Quelle scene, e le altre su temi diversi, furono raccolte in una mostra, marzo 1935, che fece gran richiamo intorno al nome del pittore nella galleria «Arbiter», in via Etnea. Un critico, Vito Mar Nicolosi, commentandole, osservò «perché e come quella che a te sembrava prosa sia invece poesia e il romanzo sia lirica. L’artista non si ferma su ciò che appare, ma vede ciò che si è e si vuole essere: qui è la sua drammaticità».
Anni felici e ricchi di contatti umani, coi letterati e artisti del tempo. Dopo Verga e De Roberto, spentisi nel ’22 e nel ’27, ecco ora altri amici: Brancati, Villaroel, Certorbi, Maganuco, Patanè, Caioli, Cardile, Manzella, Ittar. Uno di loro, il trentenne Brancati, in occasione di una mostra collettiva nel chiostro dei Benedettini, avrebbe poi scritto: «Sembra che Rimini abbia avuto l’incarico di illuminare i quadri degli altri».
Immagini luminose furono, nello stesso periodo, quelle dei pannelli decorativi nel caffè Lorenti (oggi scomparso questo e distrutti quelli), nel palazzo delle Scienze, alla Camera di Commercio. Ancora i suoi temi erano la Piana, le strade solitarie di Catania, gli angoli di campagna, i propri familiari, qualche personaggio di spicco. Fra i ritratti, ricavati da fotografie, epperò vibranti e vivi, ce ne solo due – una litografia e un carboncino – di Giovanni Verga. Il primo, molto più antico, era apparso nel 1928 sul primo numero di una rivista catanese, Le maschere, che pubblicava una commedia inedita di Verga, Rose caduche.
Venne la guerra, e, prima che cominciassero i bombardamenti su Catania, Rimini sfollò con la famiglia a Zafferana, il paese che era piaciuto a De Roberto. Gli oli, le tempere e le sanguigne di quell’epoca – ora erano la vendemmia e la montagna a ispirarlo – furono il nucleo principale di una mostra personale allestita nel 1944 a palazzo Biscari. La guerra era finita nel Meridione, lasciandovi molte rovine e molti lutti, ma proseguiva nel Nord; e lui era appena tornato a Catania. La sua arte era ormai matura «doviziosa padrona – scrisse Enzo Maganuco, storico dell’arte pittore egli stesso, amico – di tecniche e di mezzi espressivi familiari solo ai maestri che all’esercizio dell’arte stessa hanno votato appieno la loro vita».
Espose a Venezia, nel 1949, in una sala della Biennale che si chiamò Mostra degli artisti siciliani contemporanei. Tornò a esporre a Catania puntuale ogni anno, in «personali» e «collettive», suscitando ogni volta ammirazione e rispetto: aveva qualcosa da dire, possedeva la maestria per dirle, non una pennellata o un tratto di sanguigna era arbitrario o casuale.
E finalmente si arriva all’ultima tappa. Nell’estate del 1952 quest’uomo timido, discreto e, in certo modo, solitario va a passare le ferie ad Acitrezza, il paesino marinaro di padron ’Ntoni e di Piedipapera, della casa del nespolo e della «Provvidenza». Non è una terra ricca di ispirazioni questa? Si ripete, con precisione, quel che era accaduto venticinque anni prima, quando, approdato a Taormina per una vacanza, ci s’era fermato per sette anni. Ora sono le vicende del mare, e le mille facce del mare – calmo, tempestoso, livido, trasparente, amico, insidioso, – ad affascinarlo e a fargli piantar le tende lì, definitivamente.
Dalla sua terrazza, egli guarda le onde e la spiaggia, che suscitano in lui e nei suoi quadri inediti incantesimi.
Ora egli canta i Malavoglia, ed è il capitolo finale della sua vita. Lontano ormai è il mondo di Jeli il pastore e di La roba, di Fantasticheria e di Nedda; lontani nello spazio e nel tempo. È un periodo nuovo, nel quale la fatica che logora l’uomo ha altri volti e altri colori. Oggi grazia santificante, domani dannazione, ma pur sempre impegno quotidiano, il lavoro è, del resto, il credo fedele di Rimini artista e di Rimini uomo.
Come uomo e come artista Rimini fu profondamente onesto, alieno dalle brighe e lontano dalle camarille; era un poeta che «scriveva» sulle tele, un amico di cui ognuno poteva fidarsi; e aveva un cuore fanciullo, senza malizia. È per questo, forse, che ogni passo e ogni atto della sua vita hanno sempre come sfondo la serenità di chi è in pace col mondo.
Morì a ottantatré anni, la mattina del 16 febbraio 1971, ad Acitrezza, quasi all’improvviso.